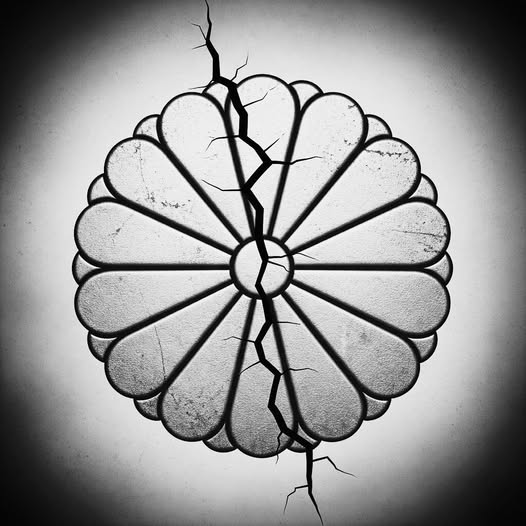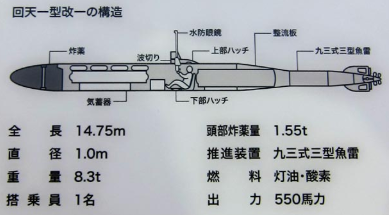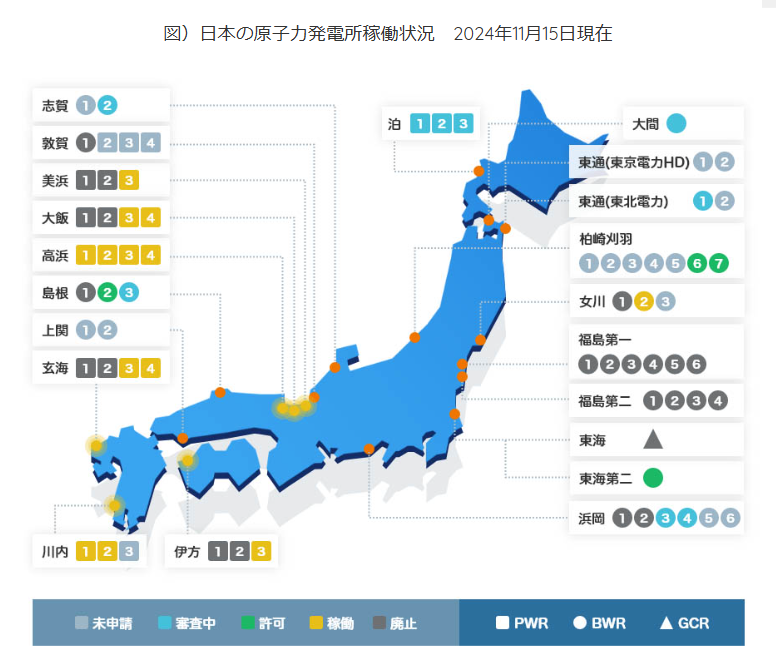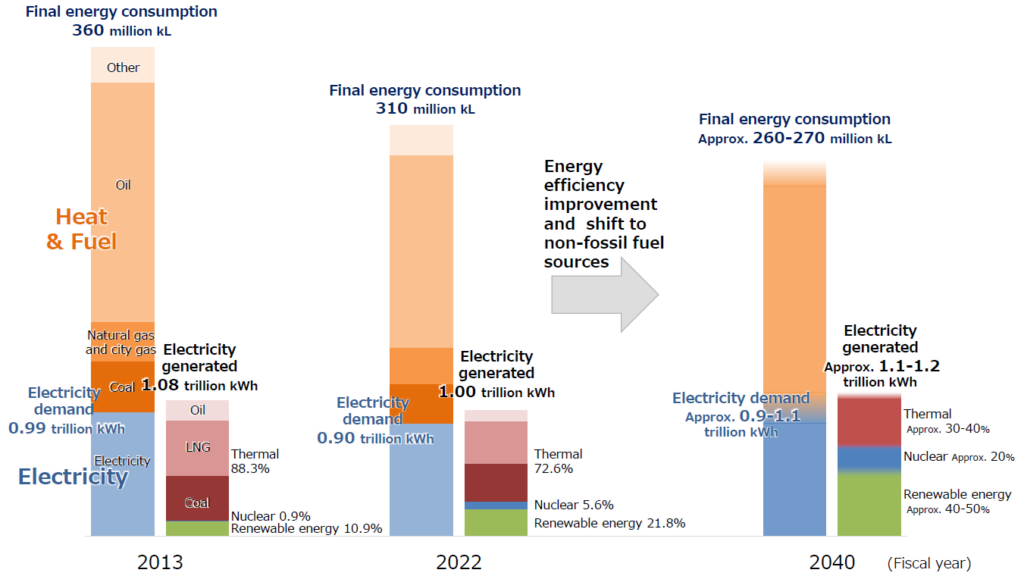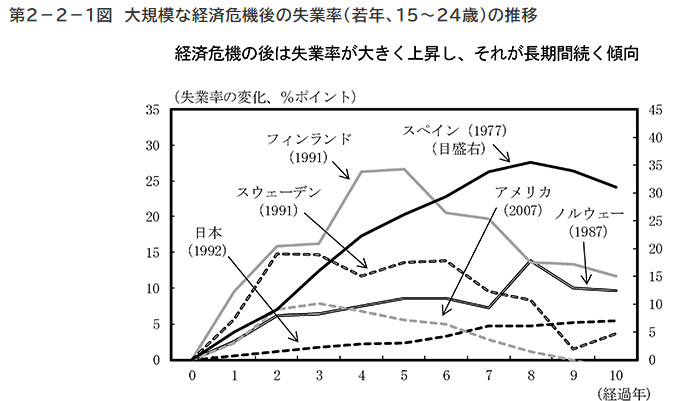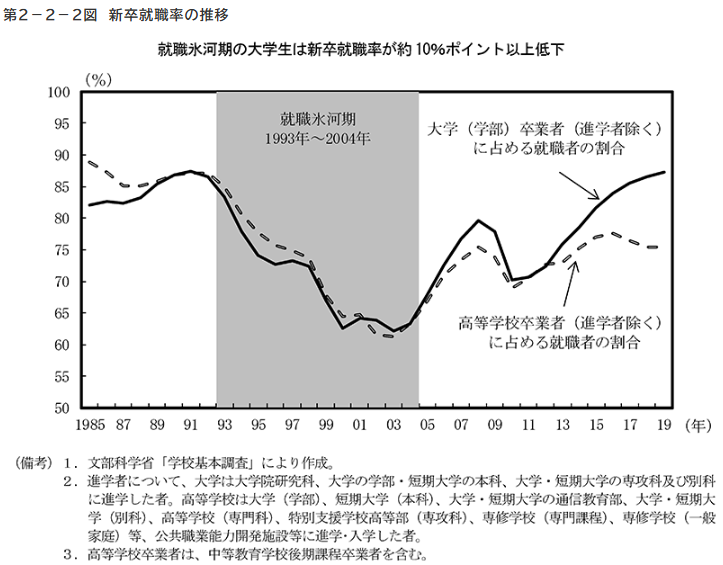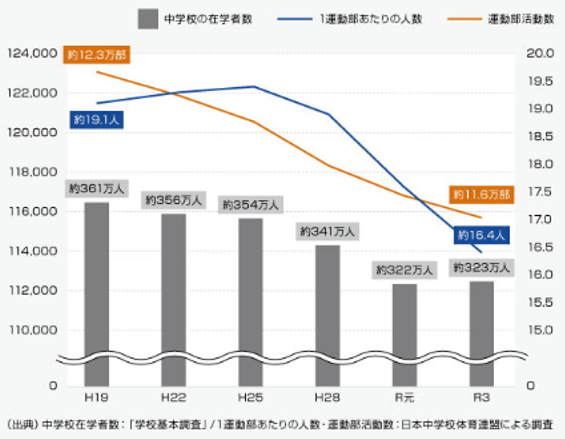15 Maggio, 1939
Caro Diario,
L’aria greve di questo maggio qui a Sasebo si mescola al fumo denso della piccola shokudō di quartiere. Le risate degli altri avventori e il tintinnio dei bicchieri riempiono a tratti il locale, ma stasera sembrano quasi distanti, un sottofondo a una tensione che sento crescere. Sono qui a Sasebo, per supervisionare alcuni aspetti tecnici legati al varo delle nuove unità per la Marina Imperiale. Di fronte a me siede Minomori-san, vecchio amico e ingegnere navale. La sua fronte è solcata da rughe che non ricordavo così profonde, mentre sorseggia il suo shōchū. Anni sono trascorsi dall’ultima volta che ci siamo visti con questa calma, eppure il nostro legame sembra immutato. Come ai vecchi tempi, da quando i miei incarichi mi portano in questa citta fortezza della Marina Imperiale, ci troviamo spesso a conversare, ma stasera il discorso ha preso una piega che mi lascia pensieroso, quasi inquieto.
“Sai,” esordisce Minomori-san, la voce più bassa del solito, quasi un sussurro carico di un peso che fatica a scrollarsi di dosso, “questi sono tempi…difficili da decifrare, non trovi? il paese cambia a una velocità che mi sconcerta. E questo kokka Shintō, lo Shintō di stato…ahimè, è diventato una forza che travolge ogni cosa, e non sempre in modi che mi convincono.” Abbassa lo sguardo, quasi a cercare le parole giuste nel fondo del suo bicchiere vuoto.
“Sì, lo percepisco ovunque,” rispondo, masticando lentamente una fetta di daikon marinato. La sua presenza è palpabile, nelle scuole, nelle cerimonie, nei discorsi ufficiali. “Ma cosa c’è realmente dietro a questa imponente spinta? Al di là del patriottismo, della lealtà quasi febbrile verso l’Imperatore…” lascio la frase in sospeso, intuendo che la sua risposta non sarà di circostanza.
Minomori-san si versa dell’altro shōchū, un gesto lento, quasi meditato. I suoi occhi, solitamente vivaci, sembrano velati da un’ombra. “È una domanda che mi pongo spesso, amico mio. E la risposta è complessa, forse scomoda. Ma se vuoi tentare di capire le radici di ciò che vedi, devi fare i conti con un nome: Hirata Atsutane.”
Annuisco. “Il nome mi è familiare. Uno dei “Quattro grandi del Kokugaku”, se non erro?”. Ho letto qualcosa sui suoi studi, sulla sua influenza.
“Proprio lui,” conferma con mezzo sorriso amaro. “Un intelletto formidabile, non c’è dubbio. Un uomo che ha voluto scavare fino a quella che credeva essere l’anima più recondita, l’essenza primigenia del Giappone. Ha tentato, con una foga quasi ossessiva, di “purificare” lo Shintō da quelle che considerava incrostazioni, le influenze buddiste e confuciane accumulate nei secoli. Voleva riportare alla luce la “via degli antichi Dèi”, le nostre credenze originarie. Un’intenzione nobile, forse, ma…” lascia la frase sospesa, e il silenzio è eloquente.
Mi porge il tokkuri, e mentre il mio bicchiere si riempie, continua con una voce ancora più sommessa, quasi guardandosi intorno: “Atsutane non era il solito filologo, un erudito come altri. Era, nel profondo, un teologo, un costruttore di sistemi. La sua visione dello yūmeikai, dell’aldila…non e un luogo di terrore, come potete immaginarlo voi occidentali, ma un mondo che si sovrappone al nostro, quasi ne fosse il doppio invisibile, l’altra faccia di una moneta. E l’aspetto cruciale, quello che oggi viene tanto…enfatizzato…e che non sarebbe un luogo di impurità. Niente kegare, dimentica quel concetto rituale. Anzi, per lui, quello era il vero mondo, eterno, infinito, mentre il nostro, questo su cui poggiamo i piedi, sarebbe solo un passaggio effimero.”
Un brivido sottile mi corre lungo la schiena, nonostante il calore del locale e dello shōchū. Ricordo alcuni passaggi dei testi che ho consultato. “Quindi, secondo questa visione, i nostri cari defunti…non sarebbero realmente scomparsi?”
Minomori-san annuisce lentamente, il suo sguardo fisso nel vuoto. “Così dicono. Ed è su questa leva emotiva, amico mio, che lo Shintō di stato fa presa con la forza. L’idea che gli spiriti degli antenati, di coloro che abbiamo amato e perduto, non siano irrimediabilmente lontani. Che siano ancora qui, “dall’altra parte del velo”, come dicono. Non svaniti, ma viventi, in una forma diversa, che coesiste con la nostra”.
Beve un altro sorso, il volto contratto in un’espressione indecifrabile. “Pensa un attimo al sollievo che un simile pensiero può infondere, specialmente di questi tempi, con tanti giovani al fronte”. La sua voce si incrina leggermente. “Sapere, o credere, o essere portati a credere, che il loro spirito non si dissolva nel nulla, ma resti a vegliare…è un conforto potente. Atsutane ha fornito una cornice, una sorta di logica a tutto questo. Ha cercato di definire dove e come gli spiriti dimorino, nel tentativo di rendere lo Shintō una dottrina che offrisse “serenità dopo la morte”. Una serenità che, temo, oggi viene usata per altri scopi.”
“È…inquietante quanto questa idea stia riemergendo con tanta forza proprio ora”, commento, riflettendo sulla sete di unità e di certezza che sembra pervadere il paese in questo clima di crescente tensione internazionale. “Sembra quasi che le sue teorie siano state dissepolte a lucidate a nuovo, per servire uno scopo preciso”.
“Altroché!” la mano di Minomori-san si stringe attorno al bicchiere. “Perché non si tratta solo di teologia, capisci? Atsutane, nel suo fervore nazionalistico, proclamò anche la superiorità intrinseca del Giappone, terra degli dei, e la natura divina del nostro Imperatore. Questa enfasi sulla discendenza diretta dalla dea Amaterasu… è diventata la colonna portante, la giustificazione ultima dell’ideologia del kokka Shintō. La lealtà verso il Trono, il patriottismo, non sono più solo doveri civici, ma atti di fede, un vincolo quasi sacrale.”
Si china leggermente verso di me, abbassando ulteriormente la voce, nonostante il rumore circostante. “E poi c’è l’aspetto più spinoso. Quello nazionalistico, intendo. Atsutane era un patriota, non c’è dubbio, ma anche profondamente avverso agli stranieri . Le sue idee hanno gettato le basi per quel sonnō jōi – Riverire l’Imperatore, espellere i barbari – che infiammò gli animi alla fine del periodo Tokugawa. E quel “espellere i barbari”… beh, non devo certo spiegare a chi si riferisse.” Un’occhiata eloquente nella mia direzione. “Ora, quello spirito, quella chiusura, quella presunzione di superiorità, sta tornando. Ma non è più come uno slogan che univa samurai ribelli; oggi è organizzato, inculcato, è…dottrina di Stato. E questo amico mio, mi spaventa.”
Guardo il mio bicchiere, ora vuoto. “Quindi, la rotta che il paese sta seguendo…affonda le sue radici molto più in profondità di quanto un osservatore esterno possa cogliere.
Minomori-san continua: “È una rotta intrapresa, e le idee di Atsutane, o meglio, l’interpretazione che se ne fa oggi, sono un vento potente che gonfia le vele della propaganda. Ma ho il terrore che questo vento ci stia spingendo verso una tempesta da cui sarà difficile uscire indenni. Il kokka Shintō non è solo un’impalcatura politica; sta cercando di plasmare l’anima stessa della nostra gente, il modo di concepire la vita, la morte, il nostro ruolo nel mondo. Offre una presunta tranquillità, la promessa che non siamo soli, che i nostri antenati vegliano. E di questi tempi, credimi “il suo sguardo si fa sempre più intenso,” molti sono disposti ad aggrapparsi a qualunque cosa pur di avere questa illusione.”
Mando giù l’ultimo sorso di shōchū. Il suo calore si diffonde, ma non riesce a scacciare un freddo interiore. Mi chiedo, osservando il volto tirato del mio amico, se in questo mondo in ebollizione, la promessa di un “dopo” così tangibile e rassicurante, così intimamente legato al destino della nazione, non possa davvero condurre a una cieca dedizione, a un sacrificio totale sull’altare di un ideale sempre più opprimente. Il sapore dello shōchū mi sembra improvvisamente più amaro.
Contesto storico
Giappone tra restaurazione e nazionalismo
La pagina di diario che ho scritto ci trasporta ancora una volta nel 1939, un periodo cruciale per il Giappone, che si trovava sull’orlo di un conflitto mondiale. In quegli anni, il paese era percorso da un forte nazionalismo e da una lealtà quasi assoluta all’Imperatore. Questo clima era alimentato da un’ideologia conosciuta come kokka shintō (国家神道), lo shintō di stato, che elevava la “religione” tradizionale giapponese al rango di dottrina ufficiale dello Stato.
Per capire una delle tante radici di questo fenomeno, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, precisamente alla fine del periodo Tokugawa e all’inizio dell’era Meiji (1868-1912). Per oltre due secoli e mezzo, il Giappone era stato un paese isolato, governato da uno shogunato militare che manteneva l’Imperatore in una posizione di prestigio, ma senza alcun potere effettivo.
La restaurazione Meiji e il ritorno dell’Imperatore
Verso la metà del XIX secolo, l’apertura forzata del Giappone all’Occidente e le crescenti pressioni interne portarono alla Restaurazione Meiji. Questo evento segnò la fine dello shogunato e il ritorno dell’Imperatore al centro della vita politica e spirituale del paese. La nuova leadership Meiji cercò di modernizzare il Giappone a ritmi serrati, ma anche di rafforzare nello stesso tempo l’identità nazionale e la coesione sociale. Fu in questo contesto che lo shintō iniziò a essere strumentalizzato per sostenere l’ideologia imperiale.
Hirata Atsutane: le radici del nazionalismo shintoista
È qui che entra in gioco la figura di Hirata Atsutane (1776-1843). Nonostante fosse vissuto prima della Restaurazione Meiji, le sue idee ebbero un influenza enorme sul nazionalismo giapponese e sullo shintō di stato (assieme alla corrente di pensiero e studi storici portati avanti dalla Mitogaku (水戸学), “la scuola di Mito”). Atsutane fu uno dei maggiori esponenti del Kokugaku (国学), una scuola di pensiero che si proponeva di riscoprire e “purificare” l’autentica cultura e spiritualità giapponese, liberandola dalle influenze buddiste e cinesi.
Atsutane, in particolare, si dedicò allo studio dello shintō, interpretandolo come la vera “religione” originaria del Giappone. Le sue teorie furono considerate rivoluzionarie per quel periodo.
“Suprematismo giapponese”: Atsutane sosteneva la “superiorità intrinseca del Giappone” come “terra degli dei”, e la natura divina dell’imperatore, discendente diretto della dea del sole Amaterasu. Questa idea divenne la pietra angolare dell’ideologia imperiale.
Concetto di aldilà: lo yūmeikai. Contrariamente alle visioni più diffuse all’epoca, influenzate dal buddismo, Atsutane sviluppo un’idea di aldilà, chiamato appunto yūmeikai, come un mondo che coesisteva con il nostro, non un luogo lontano e spaventoso, ma una sorta di altra dimensione in cui gli spiriti degli antenati continuano a vegliare sui vivi. Questa visione offriva conforto e un forte senso di continuità, specialmente in un periodo di guerre e sacrifici.
Sonnō jōi: le sue idee contribuirono a gettare le basi del movimento sonnō jōi – “riverire l’imperatore, espellere i barbari” – che infiammò gli animi alla fine del periodo Tokugawa e portò al diffondersi di un forte sentimento anti-occidentale.
Le teorie di Atsutane, pur nate in un contesto diverso, furono anch’esse interpretate e utilizzate a posteriori per giustificare lo shintō di stato. La sua enfasi sulla natura divina dell’Imperatore, sulla superiorità del Giappone e sulla costante presenza degli spiriti ancestrali, venne sapientemente impiegata per infondere un senso di lealtà sacra, patriottismo e sacrificio nel popolo giapponese, spingendo il paese verso la strada che avrebbe portato ai conflitti del XX secolo.