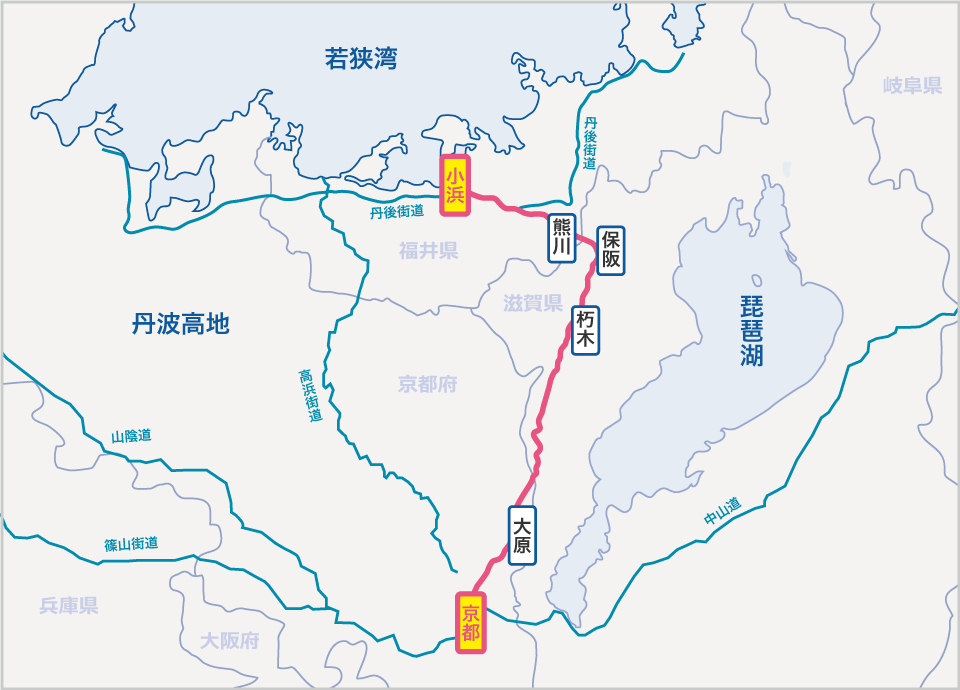Il vulcano Unzen, Unzen-dake (雲仙岳) per i giapponesi, mio vicino di casa, è un gigante in costante evoluzione. La sua attività vulcanica ha plasmato nel tempo il paesaggio della penisola di Shimabara, lasciando un segno indelebile sulla regione. Nel 1990, dopo un lungo sonno di quasi due secoli, Unzen si è risvegliato con una potente eruzione, formando una cupola di lava che ha ulteriormente trasformato l’area. Ma la storia di questo vulcano affonda radici ancora più profonde. Nel XVII secolo, i suoi inferni furono teatro di una drammatica prova di fede per i cattolici di Shimabara e della regione di Nagasaki. Unzen, dunque, è molto più di un semplice vulcano: è un testimone silenzioso della storia e della fede di queste terre e dei suoi abitanti.

Arima
Come già raccontato in un mio precedente articolo, Arima Harunobu (有馬晴信), conosciuto anche come il daimyō cristiano, era un noto protettore dei cristiani che vivevano nell’omonimo dominio che oggi corrisponde alle zone della penisola di Shimabara, nel Kyūshū. Tuttavia, un tragico inganno lo condannò a morte per ordine di Tokugawa Ieyasu e segnò l’inizio di un oscuro capitolo per la sua famiglia e per i cristiani del suo dominio. Il figlio, Naozumi Naozuni (有馬直純ま, battezzato con il nome Miguel), inizialmente seguì le orme del padre, ma ben presto abiurò la fede e si trasformò in un feroce persecutore. Nonostante la sua crudeltà, che lo portò persino a uccidere i propri fratellastri, i cristiani di Arima resistettero con tenacia, dimostrando una fede incrollabile.
Nel 1619, Papa Paolo V inviò un raggio di speranza ai fedeli giapponesi, perseguitati e isolati. La sua lettera, un faro in un mare di sofferenza, giunse ai cristiani del Giappone, tra cui quelli della regione di Shimabara.
Shimabara (島原), un tempo fiorente centro del cristianesimo in Giappone, era ormai un’isola di fede in un arcipelago di persecuzione. I suoi abitanti, tra cui figure di spicco come Paulo Uchibori Sakuemon (パウロ内堀右衛門), risposero al Papa con una lettera intrisa di gratitudine e determinazione.
In quella missiva, datata 1620 e firmata da dodici coraggiosi testimoni, i cristiani di Shimabara esprimevano la loro profonda devozione alla Chiesa e la loro incrollabile fede in Cristo. Nonostante le prove e le tribolazioni, affermarono di essere pronti a sacrificare tutto per la loro religione, dimostrando così un coraggio che ha segnato la storia del cristianesimo in Giappone. Le loro parole, cariche di emozione, riecheggiavano nella seguente frase:
“Con la grazia divina, bruciamo del desiderio di dedicare le nostre vite come testimonianza a Cristo e alla Santa Chiesa Romana”. (Questa è una mia traduzione, del testo della missiva che riporto di seguito)
ガラサ(恩恵)を以て、キリストとローマのサンタ・エケレジヤ(教会)の御證據に、身命を捧げ奉らむと、燃え立つばかり存じ奉り候。
Un toccante dettaglio emerge alla fine della lettera: il ricordo di un’udienza con Papa Gregorio XIII. Questo particolare suggerisce fortemente il coinvolgimento di Padre Julian Nakaura (ジュリアン中浦神父) nella stesura del documento. In quanto uno dei giovani ambasciatori inviati a Roma e, all’epoca, sacerdote a Kuchinotsu (口之津, una città ubicata a sud di Nagasaki ora assorbita da Minami-Shimabara), Nakaura possedeva le conoscenze e le relazioni necessarie per redigere una missiva così importante.

La lettera, inoltre, rivela un destino tragico per molti dei suoi firmatari: ben sei di loro, tra cui Paulo Uchibori, subirono il martirio. Dopo aver espresso la loro fede con tanta forza e determinazione, furono sottoposti alle più atroci torture negli inferni di Unzen.
Questo documento, quindi, va ben oltre una semplice comunicazione. È una testimonianza viva della fede incrollabile dei cristiani giapponesi, della loro profonda connessione con la Chiesa di Roma e del coraggio di coloro che scelsero di morire piuttosto che rinnegare la loro fede. La menzione di Papa Gregorio XIII, figura di riferimento per i cattolici dell’epoca, sottolinea ulteriormente il legame tra la comunità cristiana giapponese e il cuore della Chiesa universale.
Il martirio di questi fedeli, tra cui il coraggioso Paulo Uchibori e i suoi tre figli, rappresenta un capitolo cruciale nella storia del cristianesimo in Giappone. Le loro vite, consacrate a Cristo, sono un esempio luminoso di fede e di resistenza, un faro che continua a guidare i credenti di ogni tempo e luogo.
La tragedia di Shimabara: fede, potere e rivolta
Arima Naozuni si vide costretto ad abbandonare la sua terra natale e a rifugiarsi a Hyūga (odierna prefettura di Miyazaki). Al suo posto, salì al potere Matsukura Shigemasa (松倉重政), governatore noto per la sua crudeltà e la sua intolleranza religiosa. Sotto il suo dominio, i contadini di Shimabara e Amakusa, già provati da carestie e tasse esorbitanti, subirono una feroce persecuzione.
La scintilla che innescò la rivolta fu l’oppressione religiosa. I cristiani, una comunità numerosa e radicata nella regione, si trovarono sempre più schiacciati tra le maglie della repressione. Nel 1637, esasperati dalle sofferenze e dalle ingiustizie, i contadini si ribellarono, dando vita a una delle più grandi rivolte popolari della storia giapponese.
In questo contesto di violenza e caos, Arima si ritrovò in una posizione paradossale. Conoscitore profondo del territorio, fu chiamato a reprimere la rivolta che era scoppiata nella sua ex terra. Guidando un esercito di quasi quattromila uomini, si ritrovò a combattere contro coloro che un tempo erano stati i suoi sudditi. Una tragedia personale che lo segnò indelebilmente.
Mentre fuori infuriava la rivolta, all’interno della comunità cristiana si consumava un’altra tragedia. Padre Sora, un missionario che aveva dedicato la sua vita alla diffusione del cristianesimo, si trovava a Shimabara. Per sfuggire alla persecuzione, cercò rifugio a casa di Joan Nagai Naizen. Ma la loro speranza di salvezza fu di breve durata: un tradimento li condusse tra le mani dei soldati.
Paulo Uchibori, un’altra importante figura della comunità cristiana, si sentì in dovere di proteggere il suo amico e confessore. Si presentò davanti ai suoi seguaci e assunse su di sé la responsabilità di aver ospitato Padre Sora. Questo gesto di coraggio, tuttavia, non fu sufficiente a salvarli.
La notizia della rivolta e della repressione raggiunse anche Shigemasa Matsukura, che da lontano ordinò ai suoi uomini di intensificare la caccia ai cristiani. La speranza di una pacifica convivenza svanì, lasciando spazio a un clima di terrore e sospetto.
L’ombra della persecuzione: Shimabara e la fede tradita
Nel cuore dell’inverno del 1627, Shigemasa Matsukura fece ritorno dal suo dominio si Shimabara. Al suo arrivo, un’ombra sinistra aveva offuscato la sua iniziale tolleranza verso i cristiani. Durante il suo soggiorno a Edo, la capitale dello shogunato, aveva assorbito la crescente ostilità nei confronti della fede cristiana, vista come una minaccia all’unità del Giappone.
Tornato a Shimabara, Matsukura si trasformò in un feroce persecutore. Sotto la minaccia di perdere il proprio potere, impose ai cristiani del suo dominio una scelta crudele: abiurare la propria fede o affrontare le conseguenze. La comunità cristiana, profondamente radicata nel territorio, si rifiutò di cedere al ricatto. La loro tenace fede divenne così l’innesco di una spirale di violenza inaudita.
Le torture inflitte ai cristiani erano così atroci da sfidare ogni immaginazione. Tra le più crudeli, l’amputazione delle dita, un supplizio concepito per infrangere la volontà e seminare il terrore. Il 20 febbraio 1627, trentasette cristiani furono arrestati e rinchiusi nel castello di Shimabara. Tra loro, Paulo Uchibori Sakuemon e la sua famiglia.
Il martirio dei tre figli di Paulo
Davanti agli occhi terrorizzati del padre, i tre figli di Paulo, Balthazar, Antonio e Ignazio furono sottoposti a questa orribile punizione. Il primo a subire l’amputazione fu Antonio, appena diciottenne. La sua giovane età e il suo coraggio di fronte al supplizio toccarono nel profondo i presenti, diventando un simbolo della resistenza cristiana.
“Quante dita di tuo figlio dovrei tagliare?”
La domanda dell’ufficiale, posta con una freddezza che ghiacciava il sangue, risuonò come un’offesa inaudita nell’aria carica di tensione. Paulo Uchibori, con uno sguardo fiero e indomito, rispose con la stessa moneta:
“Sta a te deciderlo”
Era una sfida lanciata al potere, un atto di ribellione.
La sentenza fu inesorabile. Uno a uno, i figli di Paulo furono portati via. Antonio, il primogenito, affrontò la tortura con una dignità che lasciò tutti a bocca aperta. Mentre le lame affilate si abbattevano sulle sue mani, mutilandole, il giovane non emise un lamento. Il fratello Balthazar, commosso dalla sua forza, lo incoraggiò con voce tremante: “Ben fatto, Antonio!”. E poi fu il suo turno di affrontare il supplizio.
Infine, toccò al più piccolo, Ignazio, di soli cinque anni. Con gli occhi grandi e lucidi, il bambino guardò i suoi carnefici senza paura. Quando le sue dita furono recise, alzò le manine sanguinanti al cielo, come se le stesse offrendo in sacrificio. E in quel gesto, in quell’espressione di serena rassegnazione, c’era una tale purezza e un tale coraggio che persino i più spietati aguzzini rimasero sconcertati.

La scena era straziante. L’orrore di quel supplizio contrastato dalla fede incrollabile di quei bambini creava un contrasto così forte da incidere profondamente nell’animo di chi assisteva. Era il trionfo dello spirito sulla carne, della fede sulla violenza. In quell’inferno, la speranza non moriva.
Il gelido mare di Ariake
Sedici corpi nudi, legati come prede, furono gettati nelle gelide acque del Mar di Ariake. Cento metri li separavano dalla riva, un’infinità di sofferenza che li attendeva. Era un’esecuzione crudele, un tentativo di spezzare la loro volontà e la loro fede. Uno a uno, i martiri furono immersi nelle profondità, poi riportati in superficie, in un macabro gioco del gatto col topo. Le loro urla soffocate dal sale si mescolavano al frastuono delle onde, creando una sinfonia di dolore. Ma tra le grida, risuonavano anche parole di fede e di speranza.
Antonio rivolse uno sguardo al padre, Paulo. Nei suoi occhi, non c’era paura, ma una profonda serenità.
“Padre, ringraziamo Dio per una così grande benedizione”
sussurrò, prima di scomparire definitivamente sotto le onde. Le sue parole, cariche di fede e di coraggio, echeggiarono nella mente di tutti i presenti, diventando un inno alla speranza.
La fede cristiana era stata la loro forza in tutti questi anni di persecuzione. Avevano affrontato le torture, il disprezzo e l’isolamento, ma la loro fede era rimasta incrollabile. Ora, di fronte alla morte, la loro speranza si rivolgeva al cielo, dove li attendeva la vita eterna.
Uno dopo l’altro, i sedici martiri seguirono Antonio. I loro corpi, ormai esanimi, furono trascinati via dalle correnti, mentre le loro anime, libere dalle catene terrene, si elevavano verso il cielo. Era un sacrificio supremo, un atto di amore verso Dio e verso i propri fratelli. La loro morte non sarebbe stata vana, ma avrebbe seminato i semi della fede in cuori nuovi.

Un martirio senza fine
Paulo Uchibori, uno dei pilastri della comunità cristiana di Shimabara, fu costretto ad assistere impotente al martirio dei suoi figli. Dalla prua di una barca, vide svanire nel mare le loro giovani vite, sacrificate sull’altare della fede. Tornato a riva, la sua sofferenza non si placò. Gli aguzzini, con una ferocia inaudita, gli mozzarono tre dita da ciascuna mano e gli marchiarono la fronte con caratteri infamanti: 切支丹 (kirishitan) un marchio indelebile che lo segnava come eretico. Liberato per un breve periodo, fu presto richiuso nelle gelide celle del castello di Shimabara.
Nel passato, per indicare i cristiani in giapponese, si utilizzavano diverse combinazioni di kanji. “吉利支丹” e “貴利支丹” erano tra i più comuni. Tuttavia, con l’avvento delle persecuzioni religiose, la rappresentazione scritta dei cristiani subì una svolta negativa. Per evitare di utilizzare caratteri considerati inopportuni, come nel caso del nome dello shōgun di quel periodo Tokugawa Tsunayoshi (徳川綱吉), e per esprimere apertamente l’ostilità nei loro confronti, si diffusero termini più offensivi. “切支丹” o “鬼里至端”, ad esempio, contenevano kanji con significati negativi, come “tagliare” (切) o “demone” (鬼), e servivano a stigmatizzare e marginalizzare i fedeli cristiani.
Ma la sua fede, come quella dei suoi compagni di prigionia, era incrollabile. Venti anime, unite dal vincolo della fede, resistettero alle torture, alle privazioni e alla solitudine. Nei sotterranei del castello, le loro voci si levavano in canti di speranza, convertendo persino i carcerieri più crudeli. La loro fede era un faro in quell’oscurità, una fiamma che non poteva essere spenta.
Matsukura Shigemasa, infuriato dalla loro perseveranza, decise di porre fine a quella ribellione silenziosa. Ordinò una nuova, atroce tortura: gettare i prigionieri nelle acque bollenti degli inferni di Unzen. Così, legati e indifesi, furono gettati nell’inferno fumante, dove le loro urla si mescolarono al sibilo del vapore.
La loro morte, tuttavia, non fu la fine, ma un nuovo inizio. I martiri di Shimabara diventarono un simbolo di resistenza e di speranza per tutti i cristiani perseguitati. Le loro storie furono tramandate di generazione in generazione, alimentando la fede di coloro che vivevano nell’ombra. I loro nomi furono incisi nel cuore della comunità cristiana, diventando un monito e un esempio di coraggio e di dedizione alla propria fede.
Nel cuore dell’inferno
Il 28 febbraio 1627, le speranze di sedici cristiani, guidati da Paulo Uchibori, si infransero contro la cruda realtà. Condannati a morte, furono scortati dalle guardie verso l’Inferno di Unzen (雲仙地獄), un luogo dove la terra vomitava fuoco e l’acqua ribolliva. I rimanenti quattro furono ulteriormente interrogati prima di essere anche loro trascinati in quella macabra processione.
Un martirio atroce
Paulo Uchibori, con voce ferma e sguardo rivolto al cielo, invitò i suoi compagni a non opporre resistenza. “Aspettiamo”, disse, “che siano loro a gettarci negli inferni”. E così fecero, affidando le loro anime a Dio e invocando i nomi di Gesù e Maria.
Gli aguzzini, accecati dalla crudeltà, li gettarono uno a uno nelle acque bollenti dell’inferno. Ogni schianto contro la superficie fumante era un grido muto verso il cielo, un’attestazione di fede incrollabile.
Paulo Uchibori, simbolo di resistenza e speranza, fu riservato a un supplizio ancora più atroce. Legato mani e piedi, fu ripetutamente immerso a testa in giù nelle acque bollenti. Ad ogni immersione, le sue labbra, sfiorate dalla morte, pronunciavano un’ultima preghiera:
いとも聖き御聖体は賛美されますように。
“Benedetto sia il Santissimo Sacramento”
Questa frase, pronunciata da Paulo Uchibori mentre veniva torturato, sottolinea la sua profonda fede e devozione cristiana anche di fronte alla morte.

Il martirio di Paulo Uchibori e di altri cristiani giapponesi è una testimonianza commovente della forza della fede umana. Le loro sofferenze, seppur inumane, non hanno potuto spegnere la luce della loro speranza. Anzi, le loro vite, consacrate a Cristo, hanno brillato come stelle nel buio della persecuzione. La loro storia ci ricorda che la fede è un tesoro inestimabile, capace di sostenere l’uomo anche di fronte alla morte. Oggi, mentre guardo il vulcano Unzen da casa mia, non vedo solo una meraviglia della natura, ma anche un monumento alla fede e al coraggio di coloro che hanno sacrificato tutto per il loro credo. Il loro esempio ci invita a riflettere sul significato della nostra vita e a custodire con cura i valori che ci sono cari.