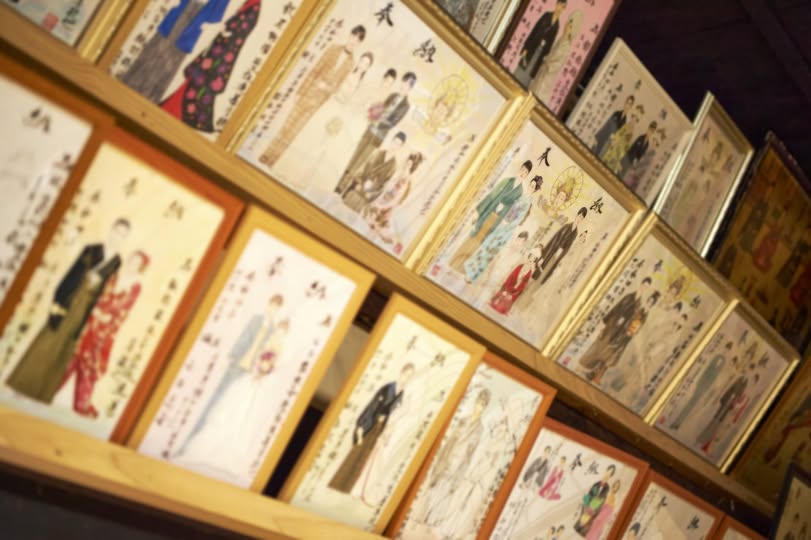Per uno straniero, ricevere un complimento pubblico o essere scelto come esempio di successo di fronte ai colleghi è quasi sempre motivo di orgoglio. Ci si sente riconosciuti, valorizzati. In Giappone, tuttavia, una situazione simile può trasformarsi in un momento di profondo imbarazzo, un’esperienza che un occidetale farebbe fatica a comprendere.
Il fulcro di questo disagio risiede nel proverbio giapponese che reicita: “Il chiodo che sporge viene martellato”. Essere messi sotto i riflettori, anche per una lode, significa “sporgere” rispetto all’armonia del gruppo. In una cultura che valorizza l’umiltà, lo sforzo collettivo e il non disturbare l’equilibrio della comunità, essere lodati individualmente può essere interpretato in diversi modi, tutti comunque negativi per l’interessato.
Innanzitutto, la persona lodata può sentirsi in colpa verso i colleghi, come se il successo individuale mettesse in ombra il contributo del team, temendo di suscitare invidia o risentimento. Invece di un “Bravo!”, nella sua testa risuona un “Perché proprio io? Ora gli altri penseranno che mi sente superiore”. In secondo luogo, l’individuo si sente sotto pressione per dover negare o sminuire il complimento in modo socialmente accettabile. Accettare apertamente una lode sarebbe visto come un atto di arroganza insopportabile. La persone di trova quindi costretta a una serie di frasi di circostanza come: “Tondemonai desu – “Niente affatto” o “Minasan no okage desu – “È tutto merito vostro”, sperando che l’attenzione si sposti da lui il più velocemente possibile.
Uno straniero con le migliori intenzioni, potrebbe insistere nel complimento, pensando di essere incoraggiante. In realtà, sta solo prolungando l’agonia del suo interlocutore giapponese, “martellando” ancora più a fondo quel chiodo che desidera soltanto tornare a livello degli altri. È un silenzioso panico sociale che svolge dietro un sorriso tirato e ripetuti inchini, un’imbarazzante danza culturale che rimane, per la maggior parte degli stranieri, completamente invisibile.
Riflettere su l’imbarazzo generato da un lode qui in Giappone significa avventurarsi in un paesaggio mentale dove tutte le nostre certezze occidentali sull’io e sul successo personale si dissolvono. Il panico silenzioso, la frenetica ricerca di umiltà, la danza sociale per deviare l’attenzione. Ma per comprendere il perché di questa reazione, bisogna scavare più a fondo, poiché non si tratta di tic della modernità, bensì di un’eco potente che risuona da un passato molto lontano.
La risposta, come spesso accade quando si parla di cose Giapponesi, non risiede nel presente ma in un sedimento storico, plasmato da necessità pragmatiche prima ancora che da precetti filosofici. Immaginiamo per un istante il Giappone rurale di secoli fa, una nazione la cui sopravvivenza era legata a un’unica, esigente cultura: il riso. La risicoltura non è un’impresa per solitari; richiede un’incredibile e meticolosa cooperazione. Canali di irrigazione, semina, trapianto e raccolto dovevano essere coordinati alla perfezione all’interno del mura, il villaggio. Un singolo individuo che avesse agito per il proprio tornaconto, deviando l’acqua o anticipando i tempi, avrebbe potuto compromettere il sostentamento dell’intera comunità. In questo contesto, l’individualismo non era un’affermazione di libertà, ma una minaccia esistenziale. Il “chiodo che sporge” non era semplicemente anticonformista; era un pericolo per tutti. L’armonia non era un ideale per lo più astratto, ma la condizione necessaria per la sopravvivenza.
Su questo pragmatismo agricolo si sono poi innestate le grandi correnti spirituali e filosofiche che hanno fornito una cornice morale a questa necessità materiale. Lo shintō, con la sua enfasi sulla purezza e sull’idea di una comunità legata a un luogo sacro, ha sempre considerato l’armonia del gruppo un valore supremo. Romperla significava creare una sorta di kegare, di impurità spirituale. Parallelamente, il buddismo, giunto sul suolo nipponico attraverso Cine e Corea, ha introdotto il concetto di muga, l’anatta, ovvero la vacuità dell’io, l’idea che l’ego e il desiderio di affermazione personale siano la radice di ogni sofferenza. Sminuire se stessi e i propri successi diventa allora non solo una norma sociale, ma anche un esercizio spirituale per trascendere l’illusione dell’ego e raggiungere la liberazione dalla sofferenza. A questa due correnti si è aggiunto in seguito il confucianesimo, che ha cementato una rigida etica sociale basata sulla lealtà, sul rispetto delle gerarchie e sul corretto adempimento del proprio ruolo all’interno della comunità. L’individuo esiste e trova il suo senso solo in relazione agli altri.
Esiste un aneddoto storico, o meglio un sistema istituzionalizzato, che cristallizza questa mentalità in modo quasi spietato: il sistema dei gonin-gumi (五人組) perfezionato durante lo shogunato Tokugawa (1603-1868). In questo sistema, le famiglie venivano raggruppate in entità di cinque e rese collettivamente responsabili per le azioni, le tasse e il comportamento di ogni singolo membro. Se una persona commette un crimine o infrange una regola, l’intera unità veniva punita. Conformarsi, mimetizzarsi e assicurasi che nessuno “sporgesse” divenne una strategia di sopravvivenza non solo individuale, ma familiare e comunitaria. La pressione sociale non era solo un sentimento, ma una legge dello “Stato”.
Questo imprinting non è svanito con la fine dello shogunato e l’avvento della modernità. È stato traslato con sorprendente efficacia dal villaggio rurale a molte aziende del XX secolo, dove la lealtà al gruppo e l’enfasi sul team sono diventati pilastri del miracolo economico del Giappone del dopoguerra. L’impiegato che oggi si sente a disagio per una lode, quindi, non sta semplicemente recitando una parte; sta inconsciamente rispondendo a un imperativo culturale forgiato da secoli di risaie, dottrine spirituali e controllo sociale. Quella che per molti stranieri è una semplice parola di incoraggiamento, per lui è una vibrazione che disturba una quiete secolare, un riflettore che lo isola pericolosamente dal rassicurante corpo della collettività. Comprendere questo sottile imbarazzo significa, in fondo, iniziare a comprendere l’anima del Giappone.